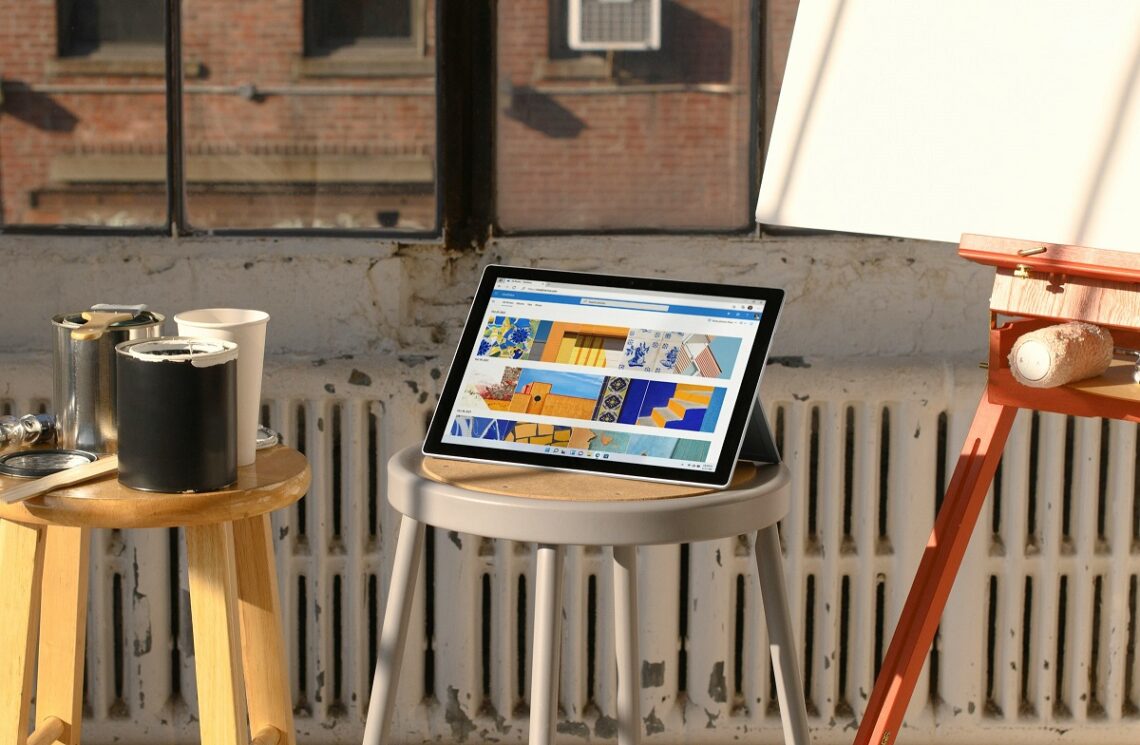Sottrarsi all’algoritmo per ritrovare sé stessi nel progetto
In un’epoca in cui gli algoritmi plasmano i nostri feed, suggeriscono immagini, prodotti, creano opere d’arte, si assiste a un fenomeno che – pur spesso vissuto come progresso – porta con sé un rischio: l’omologazione estetica. I sistemi predittivi apprendono da grandi dataset per proporci ciò che “piace” o “funziona”, contribuendo a stabilire canoni invisibili, taciti, che spesso ignorano differenze individuali o deviazioni dall’ordinario.
In questo quadro, il gusto personale e la soggettività estetica rischiano di essere compressi, appiattiti su modelli sempre più sicuri, sempre più simili tra loro.
Il problema si manifesta in vari campi: dal design d’interni alle scelte tipografiche, dalla grafica editoriale alle modalità visive dei social media. L’algoritmo “sa” quali immagini generano più interazioni, non necessariamente quali risvegliano emozioni individuali profonde. L’equilibrio instabile che si profila è quello tra efficienza, viralità e libertà estetica.
Cosa leggerai nell'articolo:
Il gusto personale come orientamento critico
Il gusto personale non è semplicemente una preferenza casuale, ma un orientamento critico che si costruisce nel tempo, attraverso esperienze, formazione, dialoghi, fallimenti, intuizioni. È un tessuto di sensibilità che non può essere codificato interamente da una rete neurale o da un modello predittivo. In ambito psicologico ed estetico, la soggettività entra come un fattore “non riducibile”, in grado di mettere in crisi il modello predittivo dell’algoritmo.
Il valore delle mani: tornare al fai da te può aiutare a vivere meglio
Questo orientamento consente di resistere alle offerte estetiche standard, di percepire dissonanze creative e di valorizzare deviazioni rispetto alle mode dominanti. In un mercato dominato da KPI visivi, click e like, il gusto personale diventa una bussola per non tradire sé stessi nel momento della progettazione.
Creatività autentica: oltre la simulazione algoritmica
In molti dibattiti recenti si chiede se un algoritmo possa essere creativo — se possa generare qualcosa di originale al di là della semplice ricombinazione statistica. Alcuni modelli, come le “Creative Adversarial Networks” (CAN), tentano esplicitamente di deviare da stili appresi per generare nuove varianti estetiche, massimizzando la “distanza” dagli stili consolidati pur mantenendo una fattura artistica.
A ogni modo, questa “creatività” rimane sempre in parte vincolata ai limiti del training e dei vincoli algoritmici. La creatività autentica umana, invece, nasce spesso dall’errore, dalla frattura, dall’intuizione che devia la traccia stabilita. Si nutre del disordine interno, della storia, del contesto culturale, della memoria affettiva. Nel dialogo uomo-macchina, il contributo umano rimane insostituibile se vogliamo preservare opere che facciano emergere la nostra irriducibile peculiarità.
Da ricerche recenti emerge che il design collaborativo con strumenti AI deve passare da un modello lineare (l’algoritmo esegue) a un modello non lineare, in cui il progettista e l’agent algoritmico dialogano, remixano, si interferiscono reciprocamente. Così facendo, l’algoritmo diviene non un esecutore, bensì un “collega” che può stimolare deviazioni inattese, sotto il controllo del gusto e dell’intenzione umana.
Soggettività estetica: rivendicare l’errore come scelta
La soggettività estetica è la capacità di attribuire valore, scelta e senso a ciò che non rientra nei canoni dominanti. È una forma di resistenza estetica che innesta l’errore, la dissonanza, il margine. In un ecosistema algoritmico, la soggettività può manifestarsi come una “scelta irregolare”, un rifiuto intenzionale dell’ottimizzazione visiva.
Questo non significa rifiutare l’uso dell’algoritmo o delle tecnologie generative, ma piuttosto incidere con decisione il proprio stile, contaminare il flusso previsto con deviazioni, inserire “scarti” intenzionali che producano fratture estetiche. È ciò che rende un progetto unico, portatore di identità, capace di resistere al rischio di omologazione.
In ambito neuroestetico computazionale, alcuni studi cercano di correlare stimoli visivi (colore, luminanza, contrasto) con le reazioni cerebrali dei fruitori, tentando di quantificare il “bello”. Tuttavia, la dimensione soggettiva – legata alla storia del fruitore e al suo immaginario – non è riducibile a un parametro computabile. La soggettività resta quel punto di frattura in cui il progetto può rompere la tendenza all’ottimizzazione visiva.
Strategie per preservare la libertà estetica nel design contemporaneo
Per chi lavora nel design, distinguere il proprio percorso estetico dalle logiche algoritmiche è essenziale. È importante costruire percorsi di riflessione, sperimentazione, autocritica, al fine di non subire passivamente le logiche del “what performs best”. L’uso consapevole degli strumenti generativi, l’intervento manuale, la contaminazione intenzionale dei modelli automatici sono strategie che consentono di preservare il proprio linguaggio visuale.
È inoltre fondamentale coltivare sensibilità estetiche diversificate attraverso l’istruzione visiva, il confronto con altre discipline e culture, la sperimentazione nel margine. Solo così il gusto personale, la creatività autentica e la soggettività estetica potranno sopravvivere – e prosperare – in un’era in cui l’omologazione algoritmica rischia di soffocarle.
[Cover Image – Foto di Microsoft 365 su Unsplash]

Il Magazine di Informazione senza filtri né padroni. Un progetto corale che arricchisce in chiave propositiva, offrendo spunti per salvaguardare il Pianeta.