Verso un’intima responsabilità del vivere con il Pianeta
Il nostro tempo ci pone davanti a domande che nelle epoche passate sembravano riservate ai poeti o ai mistici: come vivere bene in un mondo ferito, come non restare indifferenti, come traghettare la filosofia verso l’impegno concreto. L’“etica della Terra” può essere intesa come un modo di pensare che non lascia fuori il Pianeta, ma lo mette al centro: non solo come risorsa, ma come interlocutore, come soggetto, come comunità con cui intrecciamo il nostro destino.
Una simile prospettiva ricorda – e prosegue – alcune linee di pensiero già presenti nella storia filosofica classica e moderna, ripensate alla luce della crisi ambientale. Non si tratta di una filosofia astratta che tace davanti al disastro, ma di una riflessione che invita all’azione responsabile: un ponte tra pensiero e attivismo.
Arne Næss e l’ecologia profonda: “crescere il Sé” con la Terra
Il filosofo norvegese Arne Næss è considerato uno dei padri dell’ecologia profonda (deep ecology). Nel 1973 la sua famosa distinzione tra ecologia “superficiale” ed ecologia “profonda” segnò una svolta: se l’approccio superficiale mira a correggere gli effetti del degrado ambientale senza toccare le radici culturali della crisi, l’ecologia profonda invita a un ripensamento radicale della nostra relazione con la Terra.
Secondo Næss, ogni essere vivente — e più in generale ogni elemento del mondo naturale — possiede un valore intrinseco, indipendente dalla sua utilità per noi. La nostra identificazione con la Natura va oltre gli interessi puramente umani: ampliando il concetto di «Sé» (con la S maiuscola), possiamo sentirci intimamente legati al mondo naturale, a foreste, fiumi, montagne, animali. Questo processo di “self‐realization” non è egoismo, ma un allargamento della nostra casa: quando il Sé abbraccia il mondo, proteggere la Natura diventa proteggere noi stessi.
Næss non propone solo un ideale, ma invita a elaborare una propria “ecosofia” personale: una visione filosofica, etica e praticabile che orienti le scelte quotidiane. Suggerisce che capire i nostri presupposti culturali – la tendenza all’antropocentrismo, la fiducia cieca nella tecnica e nella crescita infinita – è parte essenziale del cambiamento.
In concreto, l’ecologia profonda chiede una riduzione dell’impronta umana, una rivalutazione della qualità della vita rispetto al consumismo, e politiche che non si limitino a mitigare i danni, ma trasformino le strutture sociali, economiche e ideologiche che causano il degrado.
L’idea non è che tutti debbano vivere come monaci in montagna: ma che ogni scelta (come l’uso dell’energia, il trasporto, l’alimentazione, la città) porti in sé consapevolezza del legame con Madre Terra. In questo modo filosofia e attivismo non restano separati, ma si integrano.
Spinoza: Natura, Dio e una visione unitaria del reale
Baruch Spinoza, filosofo olandese del Seicento, può apparire a prima vista lontano dalle questioni ambientali. Eppure il suo pensiero racchiude elementi che possono essere illuminanti per un’etica della Terra contemporanea. In Spinoza non esiste un Dio trascendente che governa il mondo dall’esterno, ma Dio è Natura (Deus sive Natura). Ciò implica che tutto quello che esiste — compresi gli uomini e gli ecosistemi — è manifestazione della stessa sostanza.
In questa prospettiva, separare l’uomo dalla Natura è un’illusione: non esistono estranei, non ci sono esseri doppi da dominare. L’ordine naturale non è una legge imposta dall’esterno, ma scaturisce da una necessità interna al sistema stesso.
Per Spinoza, la virtù e la felicità derivano da una vita razionale, in armonia con la realtà. L’uomo libero non è chi domina le passioni, ma chi le comprende, chi agisce secondo la ragione, chi porta il proprio conatus (sforzo di persistenza) in sintonia con l’intero. Se applichiamo questa intuizione all’ambiente, il “bene” non può essere un arbitrario obiettivo individuale, ma una vita che fluisce insieme alla Natura, in coerenza con il suo ordine.
Spinoza rifiuta il teleologismo: non ci sono fini predeterminati imposti dall’esterno alla Natura. Ogni evento nasce da necessità naturali. Questo implica che la nostra azione deve andare nella direzione della comprensione dell’ordine naturale e del nostro posto in esso, non nel tentativo di imporre scopi esterni.
Possiamo dunque trarre da Spinoza un punto etico forte: difendere la Natura non è sacrificare gli interessi umani contro gli altri, ma vivere ciò che già siamo: porzioni di Natura che riconoscono se stesse. In questo quadro, l’attivismo ecologico può essere inteso come una forma di saggezza, non una semplice pressione politica, ma una trasformazione del modo di pensare e sentire.
Verso un’etica della Terra condivisa
Un’etica della Terra che guardi al nostro tempo deve intrecciare la passione per la natura con il rigore del pensiero. Le riflessioni di Næss e di Spinoza sono due poli che dialogano: l’una insiste sul valore intrinseco e sulla responsabilità attiva; l’altra offre una visione metafisica in cui l’uomo è incorporato nella Natura stessa.
Da questo incontro possiamo ricavare alcune direttrici per una vita in armonia:
- coltivare un senso espanso del Sé che includa foreste, corsi d’acqua, animali, ecosistemi;
- trasformare le nostre scelte quotidiane (energia, trasporti, alimentazione, città) in gesti che riconoscano questo legame profondo;
- ripensare le istituzioni e le politiche non solo in termini di efficienza, ma nei termini di equilibrio ecologico, giustizia e rispetto per ciò che esiste al di là degli interessi umani immediati;
- promuovere la consapevolezza che la crisi ambientale non è un’emergenza esterna, ma un sintomo di come pensiamo il mondo e noi stessi.
L’attivismo, da questo punto di vista, non è solo protesta o resistenza, ma un esercizio filosofico: ogni azione è un atto di visione, ogni scelta quotidiana un impegno morale. E la filosofia non rimane chiusa nei libri, ma scende in strada, nei boschi, nelle comunità, in ogni pietra su cui camminiamo.
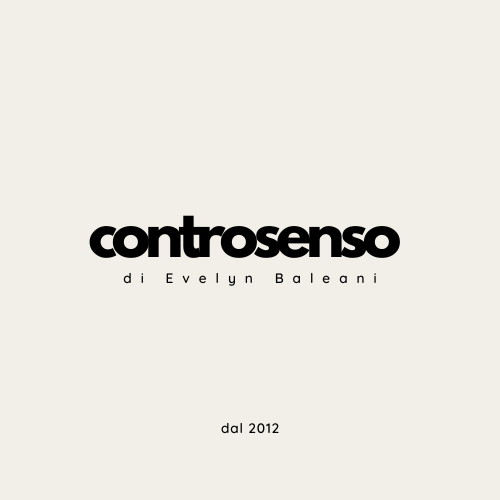
Ho ideato Controsenso, un’iniziativa che promuove la rinascita culturale. Guido un team di professionisti impegnati a supportare associazioni, cittadini, imprese e privati nella realizzazione dei loro progetti. Il nostro motto? We are working for the Planet.





