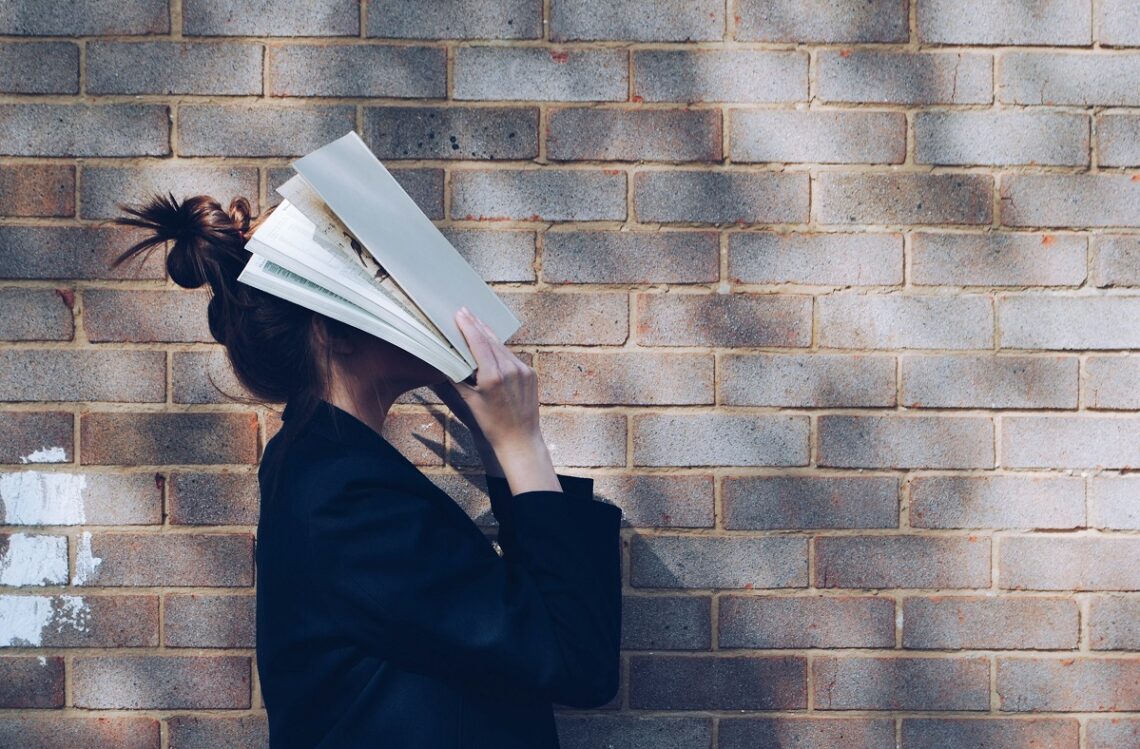In Italia più di un adulto su tre presenta difficoltà permanenti nella comprensione, nell’uso e nell’organizzazione delle informazioni scritte oltre che nel compiere semplici operazioni aritmetiche. Questo fenomeno mina la partecipazione sociale, la produttività e la qualità della cittadinanza. I numeri, le cause e le possibili vie d’uscita
Il fenomeno dell’analfabetismo funzionale — ossia la la difficoltà di comprendere, interpretare e utilizzare in modo efficace testi, numeri e informazioni nella vita quotidiana — in Italia assume proporzioni tali da definirsi una vera emergenza educativa e sociale. Secondo l’ultima rilevazione del Organisation for Economic Co‑operation and Development (OCSE) all’interno del programma Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) relativa agli adulti tra i 16 e i 65 anni, in Italia il punteggio medio in “literacy” è pari a 245, sotto la media OCSE, con il 35% degli adulti collocati al livello 1 o inferiore (contro il 26% della media OCSE). In ambito “numeracy” il quadro è analogo: 244 punti in media e 35% degli adulti al livello 1 o inferiore.
Il fenomeno appare in crescita o almeno stabile su livelli elevati: un altro rapporto indica che il 37% dei 25-64enni presenta competenze di comprensione e scrittura testi al livello elementare o inferiore, contro una media OCSE del 27%.
Se consideriamo insieme literacy, numeracy e problem solving adattivo, circa il 26% degli adulti italiani ha ottenuto i due livelli più bassi in tutte e tre le aree.
Democratizzare la cultura: perché l’accesso conta quanto i contenuti
Questi numeri, oltre ad esporre un ritardo nazionale rispetto agli altri paesi OCSE, contengono anche aspetti territoriali e generazionali di forte disuguaglianza: le performance risultano peggiori nel Mezzogiorno, e tra fasce d’età più elevate.
In sintesi, non si tratta di analfabetismo “tradizionale” (cioè non saper leggere o scrivere): in Italia questo è ormai marginale. Ma si tratta di un analfabetismo funzionale, che compromette la capacità di operare nella società della conoscenza.
Le cause: implicazioni sociali, culturali ed educative
Per comprendere le radici dell’analfabetismo funzionale occorre considerare una serie di fattori interconnessi. In primo luogo, la scuola: pur avendo fatto progressi, il sistema italiano presenta ancora lacune significative nella promozione delle competenze complesse di lettura, scrittura, calcolo e ragionamento critico. La didattica in molti casi rimane centrata sulla trasmissione di contenuti e non sulla costruzione di abilità meta-cognitive che permettano di comprendere, valutare e agire sulle informazioni.
Anche le disuguaglianze socio-territoriali giocano un ruolo rilevante: aree caratterizzate da minori investimenti, maggiori tassi di abbandono scolastico, condizioni socio-economiche più fragili, sono quelle in cui si registra la performance più bassa.
In terzo luogo, il contesto adulto: una volta concluso il ciclo formativo, la mancanza di aggiornamento continuo, la debolezza della formazione permanente (“lifelong learning”) e l’esposizione insufficiente a contesti di lettura e scrittura consapevoli favoriscono il permanere del deficit.
L’accelerazione della digitalizzazione e della società della conoscenza richiede nel contempo competenze che vanno oltre la sola alfabetizzazione di base: la capacità di navigare, selezionare, valutare informazioni e testi complessi diventa fondamentale. Il mancato adeguamento a questa sfida amplifica il divario.
Le conseguenze: perché è urgente intervenire
L’analfabetismo funzionale non è solo un problema individuale. Ha ampie ripercussioni sociali, economiche e civiche. Sul piano lavorativo, una parte consistente della forza lavoro italiana fatica a operare in contesti che richiedono la lettura e l’interpretazione di testi, la partecipazione in processi organizzativi, l’uso di strumenti digitali e la risoluzione di problemi complessi. Ciò riduce la produttività e limita le opportunità.
Sul piano della cittadinanza e della democrazia, chi ha difficoltà nella comprensione dei testi e delle informazioni è più esposto a fenomeni di disinformazione, manipolazione e isolamento culturale. Studi recenti evidenziano una correlazione tra analfabetismo funzionale e tendenza a credere fake-news o a partecipare in modo meno consapevole ai processi sociali.
Sul piano culturale e psicologico, la mancanza di padronanza nelle competenze di base genera frustrazione, bassa autostima e un circolo vizioso che alimenta la rinuncia all’apprendimento, l’autoesclusione e la marginalità. Per questo motivo l’analfabetismo funzionale rappresenta un freno all’ascesa sociale e alla coesione.
Le soluzioni all’analfabetismo funzionale: percorsi concreti
Contrastare l’analfabetismo funzionale richiede una strategia integrata che coinvolga scuola, famiglie, adulti, sistema formativo e imprese. Va rafforzata la scuola: occorre puntare su didattiche che favoriscano la comprensione profonda, l’argomentazione, la capacità di scrivere in modo autonomo e critico. La scuola deve diventare un laboratorio di competenze reali, non solo un luogo di trasmissione.
In parallelo, va potenziata la formazione permanente per gli adulti (“lifelong learning”). È necessario offrire percorsi accessibili, modulari e personalizzati che permettano anche a chi è fuori dal sistema scolastico di recuperare e sviluppare competenze di base. I centri territoriali per l’educazione degli adulti (CPIA) e i programmi aziendali di alfabetizzazione sono esempi di possibili strumenti da adottare per l’incremento dell’alfabetizzazione funzionale.
La famiglia e l’ambiente domestico rappresentano il primo terreno fertile per contrastare l’analfabetismo funzionale. Coltivare l’abitudine alla lettura, stimolare la curiosità e accompagnare i figli nella scoperta del significato dei testi significa gettare le basi di un pensiero critico. Offrire uno spazio in cui la scrittura e il ragionamento siano parte della quotidianità aiuta i più giovani a percepire la conoscenza come uno strumento di libertà, non come un dovere.
Il primo motivo che deve condurci allo studio è l’intima soddisfazione che si prova nel vedere il nostro essere diventare sempre più eccelso e nel rendere ancora più intelligente un essere intelligente – Charles-Louis de Montesquieu
Anche la tecnologia, se usata con intelligenza, può diventare un’alleata preziosa. Piattaforme interattive, micro-contenuti digitali, formati audio e video, nonché la simulazione di contesti reali, rendono l’apprendimento più accessibile e coinvolgente, soprattutto per chi incontra difficoltà o per gli adulti che studiano e lavorano.
Serve però anche una visione politica di lungo respiro. L’analfabetismo funzionale va riconosciuto come una priorità nazionale, da affrontare con un monitoraggio costante, finanziamenti mirati e una governance integrata capace di connettere istruzione, lavoro e politiche sociali.
Solo con una strategia lungimirante l’Italia potrà costruire una cultura davvero inclusiva, fondata sulla conoscenza e sulla consapevolezza.
Saper leggere e scrivere non è più sufficiente: bisogna comprendere, ragionare, partecipare. Un presupposto cruciale per un Paese evoluto.

Il Magazine di Informazione senza filtri né padroni. Un progetto corale che arricchisce in chiave propositiva, offrendo spunti per salvaguardare il Pianeta.