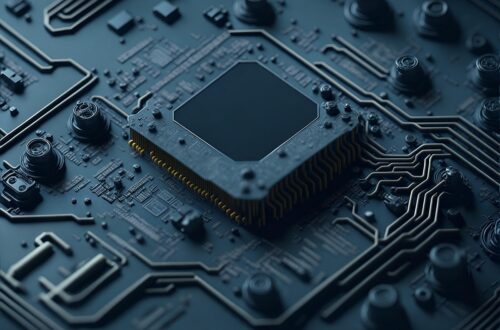Il fototropismo negativo è un fenomeno meno noto rispetto al classico fototropismo positivo (la crescita verso la luce), ma riveste un ruolo cruciale in determinate specie vegetali. Di cosa si tratta?
Il fototropismo è la capacità di un organo vegetale di deviare la propria crescita in risposta a un’illuminazione direzionale. Se la deviazione è verso la fonte luminosa, parliamo di fototropismo positivo; se invece la crescita è orientata lontano dalla luce, si parla di fototropismo negativo.
Non va confuso con lo skototropismo, ovvero la crescita attiva verso l’oscurità (cioè verso l’ombra), malgrado nei casi naturali i due fenomeni possano sovrapporsi nel comportamento della pianta.
Il fototropismo negativo è meno comune nei tessuti aerei delle piante (steli, germogli), mentre è osservato più spesso nelle radici (specialmente esposte alla luce), in strutture specializzate o in piante rampicanti che cercano supporti in zone meno illuminate.
Meccanismi fisiologici e ormonali
Alla base del fototropismo, positivo o negativo, ci sono differenze nella distribuzione dell’ormone auxina – o nella sensibilità delle cellule all’auxina – che inducono variazioni nel ritmo di allungamento delle pareti cellulari sui diversi lati dell’organo. Nel modello classico di Cholodny-Went (anni ’20) si ipotizza che la luce induca un trasporto asimmetrico di auxina verso il lato ombreggiato dell’organo, stimolando la crescita da quel versante.
Quando il flusso di auxina o la sensibilità cellulare è ridotta, o quando entrano in gioco altri segnali, la risposta può invertire direzione e dare origine a fototropismo negativo.
Ulteriori elementi coinvolti sono proteine di trasporto dell’auxina (come le proteine PIN), regolatori interinali come flavonoli, segnali di ossido-radicali (ROS), pH, e interazioni con altri stimoli gravitropici o idrotropici.
Negli anni recenti si è discusso dell’escape tropism, una risposta nella quale la radice (o organi sensibili) si allontana dalla luce come reazione di stress, cercando condizioni ambientali più favorevoli.
Esempi naturali: radici e piante rampicanti
Un caso classico si ha nelle radici che, se esposte alla luce (per esempio in condizioni sperimentali), mostrano spesso fototropismo negativo, cioè crescono lontano dalla superficie luminosa verso zone più scure e profonde.
Libri consigliati. Plant Revolution di Stefano Mancuso: un viaggio nella coscienza delle piante
Anche nelle iante rampicanti, il fenomeno assume una funzione adattativa interessante: alcune specie usano il fototropismo negativo per dirigersi verso zone più in ombra, dove possono trovare supporti solidi su cui arrampicarsi.
Nel caso della pianta sudamericana Hydrangea serratifolia, il fototropismo negativo è stato interpretato come un meccanismo di ricerca di supporti: i germogli “cercano” la zona più ombreggiata del tronco dell’albero vicino.
Implicazioni evolutive e sperimentali
Dal punto di vista evolutivo, il fototropismo negativo può rappresentare un vantaggio competitivo in ambienti densi o in ecosistemi forestali. Le piante rampicanti possono avvantaggiarsene nel trovare supporti strutturali nella densa ombra della foresta, mentre le radici evitano l’illuminazione che può causare stress ossidativo.
Sotto il profilo sperimentale, il fenomeno è usato nello studio delle vie di segnalazione dell’auxina, dell’interazione tra stimoli contemporanei (luce, gravità, acqua) e nella comprensione degli adattamenti delle piante in condizioni estreme. In ambienti con microgravità, ad esempio, l’assenza del segnale gravitropico rende più evidente la competizione tra fototropismo positivo / negativo.
La complessità delle risposte (coinvolgimento di ROS, flavonoli, pH, cinetica di trasporto) rende oggi il fototropismo negativo un caso modello per studiare plasticità, regolazione e integrazione dei segnali ambientali negli organismi vegetali.

Il Magazine di Informazione senza filtri né padroni. Un progetto corale che arricchisce in chiave propositiva, offrendo spunti per salvaguardare il Pianeta.