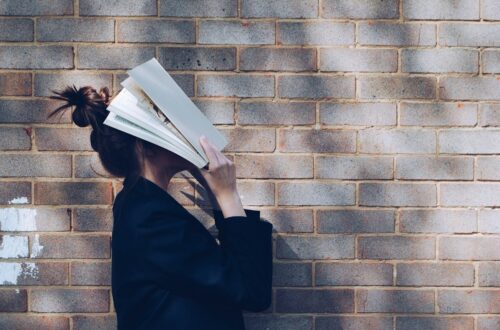Il gracchio alpino, corvide alpestre con becco giallo e zampe rosso-arancio, manifesta complesse strategie di adattamento diurne e gregarie, mostrando plasticità ecologica tra quote elevate, aree turistiche e ambienti antropizzati
Il gracchio alpino (Pyrrhocorax graculus) è un uccello appartenente alla famiglia dei corvidi, ben riconoscibile grazie al becco giallo e all’eccezionale abilità di volo in alta quota. Presente principalmente sulle Alpi e altre catene montuose del Sud Europa e del Marocco, questa specie unisce caratteristiche biologiche interessanti a un’elevata sensibilità agli impatti antropici.
Cosa leggerai nell'articolo:
Distribuzione e habitat
La distribuzione è tipica delle regioni montane: in Europa il gracchio alpino nidifica preferenzialmente tra i 2.000 e i 3.500 metri, con record di nidificazione oltre i 6.500 metri e occasioni di volo osservate fino a 8.200 metri sull’Everest.
È presente sulle Alpi, i Balcani, la Corsica e in Marocco, con colonie più isolate su alcune creste appenniniche centro-meridionali.
L’habitat comprende ambienti rupestri associati a prati aperti e pascoli, elementi essenziali per le aree di foraggiamento.
Specie diurna e gregaria, il gracchio alpino forma stormi che possono comprendere da una dozzina sino a oltre un migliaio di individui, soprattutto in estate quando il cibo abbonda. Durante l’inverno, gli esemplari frazionano spesso il gruppo.
Gli spostamenti giornalieri possono raggiungere un raggio di 20 km e variazioni altitudinali fino a 1.600 m per trovare zone di alimentazione adeguate. Di sera gli uccelli tornano ai posatoi situati su pareti rocciose riparate.
Ti suggeriamo di leggere: Stambecco, simbolo delle vette rocciose
All’interno degli stormi è presente una gerarchia sociale rigida: in condizioni di scarsezza alimentare gli adulti dominano sugli esemplari giovani e i maschi sulle femmine.
Alimentazione e strategie di sopravvivenza
La dieta varia stagionalmente: nei mesi estivi predomina l’alimentazione insettivora, con piccoli coleotteri, lumache, bruchi e cavallette. In autunno e inverno prevalgono bacche, frutta selvatica e, in assenza di scorte adeguate, i rifiuti alimentari presenti nelle aree turistiche frequentate da escursionisti.
La specie pratica anche l’hoarding, ovvero la prassi di nascondere il cibo nelle crepe rocciose, coprendolo con sassolini per consumarlo successivamente.
Riproduzione e ciclo vitale del gracchio alpino
Il gracchio alpino è monogamo e le coppie restano unite a vita, dimostrando una forte filopatria verso il sito di nidificazione, che tendono a riutilizzare ogni anno. La nidificazione comincia generalmente a maggio: il nido, costruito da entrambi i genitori con rametti, erba e pelame, è situato in anfratti rocciosi o grotte.
La femmina depone 3‑5 uova che cova per 14‑21 giorni, mentre i pulli restano nel nido circa 29‑35 giorni prima dell’involo. L’adattamento alle altitudini estreme include uova con minore porosità e embrioni dotati di emoglobina ad alta affinità per l’ossigeno.
Conservazione e minacce
A livello globale, lo stato di conservazione del gracchio alpino è classificato come “Least Concern”, secondo la Lista Rossa IUCN, perché la specie non raggiunge soglie di declino superiore al 30% in tre generazioni.
Nella cornice europea questa specie è inserita nella Direttiva Uccelli dell’UE ed è tutelata in molti siti Natura 2000, inclusi oltre 110 siti italiani nelle Alpi.
In Italia la popolazione stimata tra Alpi e Appennino è di circa 5.000‑15.000 coppie; mentre quella alpina risulta stabile, l’Appennino centrale mostra segnali di declino ed alcune estinzioni locali negli ultimi decenni.
Ti suggeriamo di leggere: Aquila reale, biologia e conservazione
La minaccia principale si riscontra nella perdita o nella trasformazione dei prati alpini e pascoli tradizionali, causata dall’abbandono o dallo sviluppo turistico correlato alla realizzazione di piste da sci o infrastrutture in quota, che alterano habitat fondamentali per il foraggiamento e la nidificazione di molte specie. La dipendenza crescente da risorse alimentari antropiche nelle aree turistiche può modificare i movimenti naturali e il comportamento del gracchio alpino, inducendo una dipendenza che altera il ciclo altitudinale stagionale.
Un esempio di resilienza montana
Il gracchio alpino emerge come un modulo ecologico di resistenza montana, capace di vivere e di riprodursi in condizioni estreme grazie a sofisticate strategie comportamentali e fisiologiche.
La stabilità di molte popolazioni dipende però strettamente dalla conservazione dei pascoli e delle praterie alpine tradizionali e dal controllo delle distorsioni prodotte dall’antropizzazione. Interventi mirati, sia a livello locale che transnazionale, risultano fondamentali per garantire la persistenza di questa specie iconica dei cieli alpini.
Per approfondimenti sulle dinamiche recenti e progetti di conservazione si suggerisce di consultare BirdLife International, i rapporti del Parco Gran Sasso e le pubblicazioni scientifiche a tema.
Box di approfondimento – Che cosa significa filopatria?
Il termine “filopatria” deriva dal greco antico e significa letteralmente “amore per la patria” (philos = amore, patris = patria). In ambito zoologico, la filopatria indica il comportamento di alcuni animali che tendono a tornare, anno dopo anno, nello stesso luogo per riprodursi o stabilirsi.
Questo fenomeno è particolarmente diffuso tra gli uccelli, compreso il gracchio alpino, che spesso torna a nidificare esattamente nello stesso anfratto roccioso utilizzato in stagioni riproduttive precedenti.
La filopatria può avere vantaggi evolutivi, come la conoscenza del territorio e delle sue risorse, ma può anche rendere la specie più vulnerabile ai cambiamenti ambientali improvvisi, soprattutto se i siti abituali vengono alterati o distrutti.
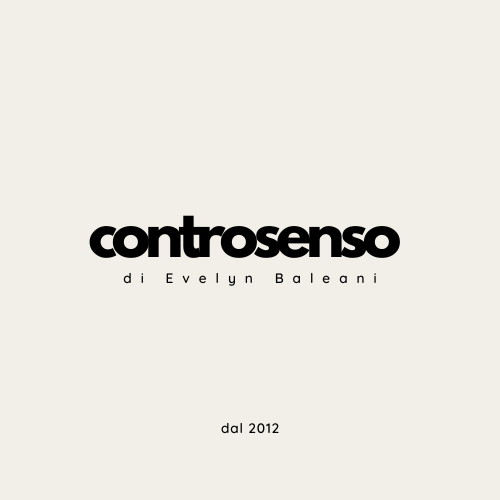
Ho ideato Controsenso, un’iniziativa che promuove la rinascita culturale. Guido un team di professionisti impegnati a supportare associazioni, cittadini, imprese e privati nella realizzazione dei loro progetti. Il nostro motto? We are working for the Planet.