Una riflessione sui pericoli ambientali nascosti dietro la promessa dell’ingegneria genetica, tra ibridazioni, resistenza e perdita irreversibile di varietà naturali
Negli ultimi decenni, la biotecnologia ha offerto la suggestiva promessa di piante più produttive e resistenti. Tuttavia, dietro la facciata del progresso agrario si nascondono rischi concreti per la biodiversità. Gli organismi geneticamente modificati (OGM), progettati per massimizzare la resa o la resistenza a parassiti, possono acquisire un vantaggio competitivo nei confronti delle specie selvatiche locali.
Questo squilibrio, oltre a compromettere la diversità genetica, può trasformare colture transgeniche in veri e propri “invasori ambientali”.
Cosa leggerai nell'articolo:
- Flusso genetico e ibridazione: il pericolo del contagio tra specie
- Selezione artificiale e resistenza: un boomerang per l’ambiente
- Impatti sul suolo e sui cicli biogeochimici
- Estinzione teorica e perdita di specie naturali
- Rischi di sorveglianza e tracciabilità
- Verso una regolazione più prudente e attenta
Flusso genetico e ibridazione: il pericolo del contagio tra specie
Uno dei principali timori legati agli OGM riguarda il trasferimento di geni modificati alle piante selvatiche o ad altre colture strettamente imparentate. Attraverso l’impollinazione, i transgeni possono “fuggire” dai campi coltivati e mescolarsi con la flora spontanea, dando origine a ibridi con caratteristiche imprevedibili.
In alcuni casi, queste piante ibride possono essere più competitive rispetto alle loro controparti naturali, grazie alla resistenza conferita dai geni modificati, e potrebbero soppiantarle, riducendo la variabilità genetica e quindi la resilienza degli ecosistemi.
Selezione artificiale e resistenza: un boomerang per l’ambiente
Molte piante OGM sono state progettate per tollerare erbicidi o per esprimere tossine letali per insetti dannosi. Da un lato questa caratteristica può ridurre l’uso di pesticidi tradizionali. Dall’altro, però, l’uso massiccio di tali tecnologie favorisce la selezione di infestanti ed insetti resistenti che accumulano mutazioni sempre più problematiche.
L’impatto del consumo di suolo sulla biodiversità italiana: un’emergenza ignorata
La resistenza chimica necessariamente spinge, inoltre, gli agricoltori a usare dosi più elevate di diserbanti o a ricorrere a sostanze sempre più aggressive, con impatti negativi per gli insetti non target e per il suolo.
Impatti sul suolo e sui cicli biogeochimici
Gli OGM possono anche modificare la dinamica più sottile e fondamentale degli ecosistemi, cioè il ciclo dei nutrienti nel suolo. Secondo le linee guida europee per la biosicurezza, tra gli aspetti da valutare vi sono i possibili effetti sulla decomposizione della materia organica e sui cicli del carbonio e dell’azoto.
Quando una pianta esprime una tossina (come quelle derivanti da Bacillus thuringiensis, Bt), questa può alterare il microambiente del suolo, condizionando la comunità microbica e la decomposizione: un’alterazione che, a lungo termine, può compromettere la fertilità e la salute degli agro-ecosistemi.
Estinzione teorica e perdita di specie naturali
A livello più ampio, alcuni ricercatori avvertono di un rischio teorico non trascurabile: l’introduzione di OGM in popolazioni naturali potrebbe aumentare il pericolo di estinzione. In uno studio, gli scienziati William Muir e Richard Howard hanno simulato scenari in cui il trasferimento di geni modificati, unito alla competizione selettiva, potrebbe spingere specie naturali al collasso.
Sebbene si tratti di modelli teorici, il fatto che l’ingegneria genetica possa alterare gli equilibri evolutivi solleva questioni profonde sul rispetto e la conservazione delle specie autoctone.
Rischi di sorveglianza e tracciabilità
Un altro fronte critico riguarda il controllo post-autorizzazione: l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) richiede piani di monitoraggio ambientale (PMEM) per individuare eventuali effetti nocivi dopo il rilascio sul mercato. Ma la recente proposta di abrogare gli obblighi di tracciabilità per i “nuovi OGM” (tecniche di evoluzione assistita, TEA) ha sollevato preoccupazioni da parte di varie associazioni ambientali che temono perdite di trasparenza e responsabilità in caso di contaminazione.
Il viaggio segreto del polline: come avviene l’impollinazione
Senza una tracciabilità adeguata, diventa più difficile risalire all’origine di eventuali impatti negativi sull’ambiente e prendere misure correttive.
Verso una regolazione più prudente e attenta
Per proteggere la biodiversità, è essenziale adottare un approccio p
rigoroso. Ciò significa valutare il rischio prima del rilascio, ma anche monitorare costantemente e a lungo termine gli effetti nel suolo, nelle popolazioni selvatiche e nei cicli ecologici.
Le strategie di contenimento, la definizione di limiti geografici o barriere fisiche, e il mantenimento della tracciabilità dei nuovi OGM sono misure indispensabili per evitare che i presunti benefici dichiarati dell’ingegneria genetica si traducano in costi irreversibili per la natura.
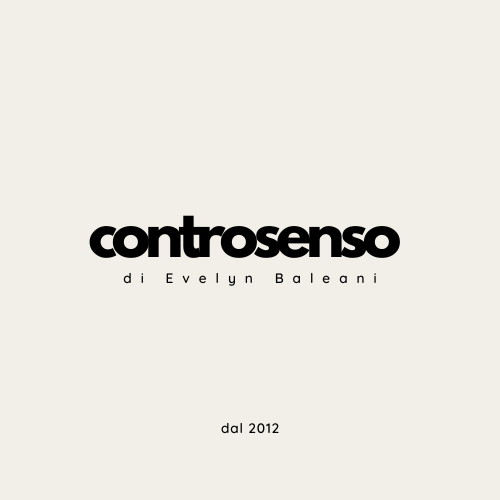
Ho ideato Controsenso, un’iniziativa che promuove la rinascita culturale. Guido un team di professionisti impegnati a supportare associazioni, cittadini, imprese e privati nella realizzazione dei loro progetti. Il nostro motto? We are working for the Planet.




