Il buco nell’ozono è in via di chiusura, ma non è ancora guarito. 38 anni dopo il Protocollo di Montréal, più che festeggiare è necessario vigilare
Ogni 16 settembre il mondo celebra la Giornata Internazionale per la Preservazione dello Strato di Ozono, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1994 per ricordare la firma del Protocollo di Montréal, avvenuta nel 1987. Un accordo che rappresenta ancora oggi il più grande successo della cooperazione internazionale in campo ambientale.
È grazie a quel patto globale che l’umanità ha deciso di ridurre drasticamente l’uso delle sostanze responsabili della distruzione dell’ozono stratosferico, i cosiddetti ODS, aprendo la strada a un lento ma significativo recupero della protezione naturale che ci difende dai raggi ultravioletti.
Cosa leggerai nell'articolo:
Lo stato di salute dello strato di ozono
Gli ultimi dati disponibili, aggiornati al 2025, confermano che lo strato di ozono sta migliorando. Negli emisferi settentrionali e nelle latitudini medie il recupero procede con una crescita stimata tra l’1 e il 3% per decennio rispetto agli anni Duemila.
Le proiezioni scientifiche indicano che ai livelli pre-1980 si potrebbe tornare già negli anni Trenta del secolo in corso per l’emisfero nord, mentre servirà attendere la metà del secolo per quello sud.
Il recupero completo in Antartide, invece, richiederà ancora tempo, con una chiusura del buco stimata intorno al 2060. È una notizia che porta con sé speranza, ma anche la consapevolezza che il traguardo è ancora distante.
Una vittoria ambientale e climatica
La riduzione degli ODS non è stata solo una vittoria ambientale, ma anche climatica. Molte di queste sostanze sono infatti potenti gas serra, e la loro eliminazione ha contribuito a contenere l’ulteriore surriscaldamento globale.
Il quadro, tuttavia, presente delle ombre. Restano da affrontare le emissioni residue legate a vecchie apparecchiature, a stock non smaltiti e a importazioni illegali. Inoltre, alcuni sostituti introdotti negli anni, come gli idrofluorocarburi (HFC), pur non danneggiando l’ozono, hanno un impatto rilevante sul clima e richiedono ora una nuova fase di riduzione graduale stabilita nell’Emendamento di Kigali.
Le nuove preoccupazioni scientifiche
Un altro elemento che preoccupa la comunità scientifica è l’aumento dell’ossido di azoto, legato soprattutto all’uso di fertilizzanti in agricoltura. Questa sostanza non è regolata dal Protocollo di Montréal, ma rappresenta oggi il principale fattore chimico capace di incidere sull’ozono, oltre a essere un potente gas serra.
La sua crescita mette in evidenza come la sfida sia ormai interconnessa tra tutela dello strato di ozono e lotta al cambiamento climatico, due facce della stessa medaglia.
Il caso europeo
In Europa i risultati raggiunti sono evidenti: dal 1986 a oggi il consumo di sostanze che riducono l’ozono è calato del 99%. Eppure, nonostante questo traguardo, i dati del 2023 hanno registrato un lieve aumento rispetto all’anno precedente, segnale che la gestione di stock, importazioni e distruzioni non è ancora del tutto priva di criticità. La strada dunque rimane segnata, ma non completata.
Una protezione che riguarda tutti
Non si tratta solo di una questione tecnica o diplomatica. Lo strato di ozono ci riguarda da vicino, perché è lo scudo che filtra i raggi ultravioletti che altrimenti provocherebbero un aumento dei tumori della pelle, delle cataratte e di altre gravi patologie.
Un suo indebolimento mette a rischio gli ecosistemi, rallenta la fotosintesi delle piante, danneggia il fitoplancton marino e, di conseguenza, mina le catene alimentari da cui dipendiamo. Preservare l’ozono significa dunque proteggere la salute umana e la stabilità degli equilibri naturali.
Il valore del Protocollo di Montréal
Il Protocollo di Montréal, firmato da quasi tutti i paesi del mondo, resta un modello di successo: dimostra che la cooperazione internazionale può funzionare, e che la scienza, se sostenuta dalla politica, è in grado di cambiare la traiettoria del nostro futuro.
Tuttavia, non basta celebrare. La lezione che arriva da questa Giornata Internazionale è che l’attenzione non può calare, perché la storia dello strato di ozono ci insegna che la tutela ambientale non è mai definitiva, ma richiede impegno costante, monitoraggio accurato e scelte lungimiranti.
Se oggi il buco nell’ozono è in via di chiusura, lo dobbiamo a decenni di azioni coordinate. Eppure, il cammino verso la piena guarigione non è ancora compiuto. La sfida è continuare a vigilare, ad adattare le politiche, a rendere consapevoli le persone. Solo così il cielo che ci sovrasta potrà davvero tornare a essere la protezione silenziosa di cui l’intero Pianeta ha bisogno.
Box di approfondimento – Cosa possiamo fare
- Ridurre l’uso di prodotti che contengono gas refrigeranti ODS/HFC (controllare gli impianti di condizionamento, scegliere sostituti green).
- Supportare politiche che favoriscano l’efficienza energetica, l’uso di tecnologie pulite, e regolamentazioni ambientali rigorose.
- Informarsi e condividere: far conoscere il Protocollo di Montréal, il ruolo dell’Emendamento di Kigali, i rischi che ancora persistono.
Box di approfondimento 2 – Emendamento di Kigali
L’Emendamento di Kigali è un aggiornamento del Protocollo di Montréal approvato il 15 ottobre 2016 a Kigali, in Ruanda. È entrato in vigore il 1° gennaio 2019 e riguarda la regolamentazione degli idrofluorocarburi (HFC).
Gli HFC non danneggiano direttamente lo strato di ozono, ma sono gas serra estremamente potenti, in alcuni casi fino a migliaia di volte più impattanti dell’anidride carbonica. Vengono usati soprattutto nei condizionatori d’aria, refrigeratori, pompe di calore e aerosol come sostituti dei clorofluorocarburi (CFC) e degli idroclorofluorocarburi (HCFC), che invece intaccavano lo strato di ozono.
Con l’Emendamento di Kigali, i paesi firmatari si sono impegnati a ridurre progressivamente la produzione e il consumo di HFC, seguendo un calendario differenziato:
- Paesi sviluppati. Riduzione dell’85% entro il 2036 rispetto ai livelli di riferimento.
- Paesi in via di sviluppo. Hanno più tempo, con obiettivi distribuiti tra il 2045 e il 2047 a seconda dei gruppi.
Secondo le stime dell’UNEP, l’attuazione completa dell’Emendamento potrebbe evitare fino a 0,4 °C di riscaldamento globale entro la fine del secolo, contribuendo in maniera significativa agli obiettivi dell’Accordo di Parigi.
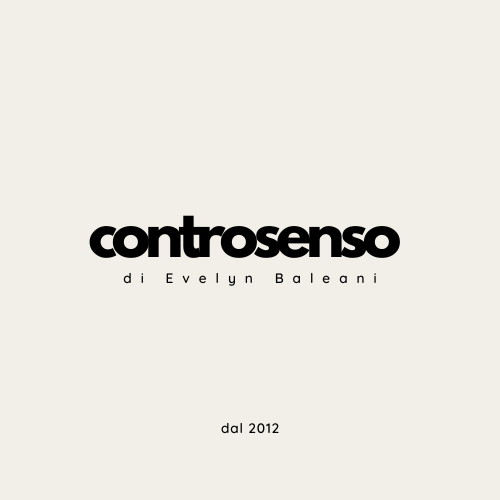
Ho ideato Controsenso, un’iniziativa che promuove la rinascita culturale. Guido un team di professionisti impegnati a supportare associazioni, cittadini, imprese e privati nella realizzazione dei loro progetti. Il nostro motto? We are working for the Planet.





